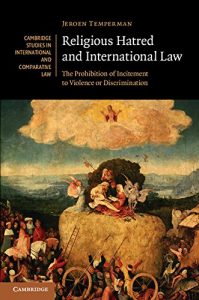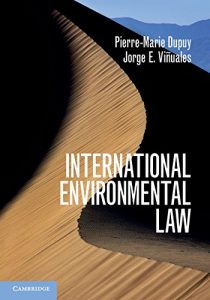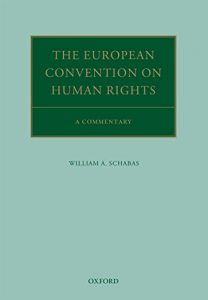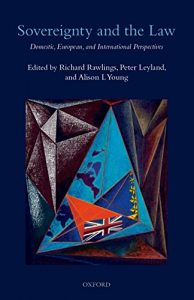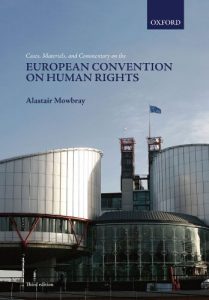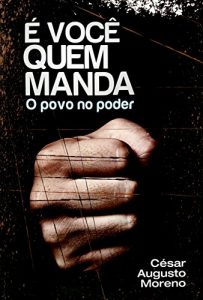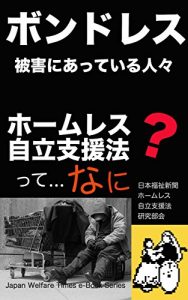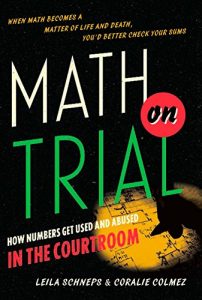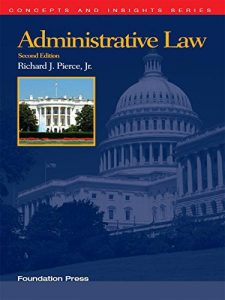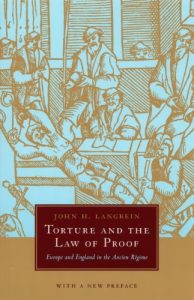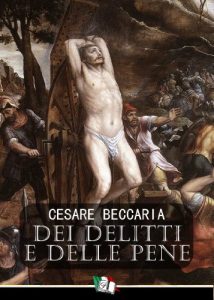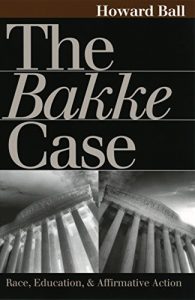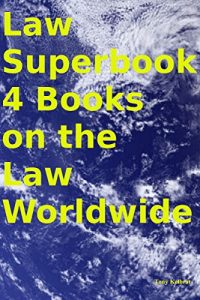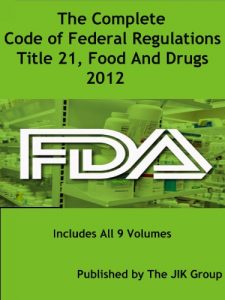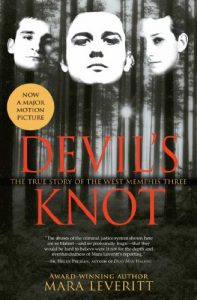I 99eBooks è una directory di eBook. Cerchiamo e classificato intorno alle eBooks Web per te!
Tutti i diritti riservati. I libri e libri elettronici sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Diritto di voto. Problematiche costituzionali e attuali prospettive.: Tesi in Diritto Costituzionale presentata presso Alma Mater Studiorum di Bologna
Tesi di laurea in Diritto Costituzionale presentata presso l'ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA - Scuola di Giurisprudenza - Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dal Dott. Tronchin Luigi nella II sessione di laurea dell'anno accademico 2013-2014.
La partecipazione della popolazione al governo del Paese è il fulcro della democrazia. Più questa partecipazione è difesa, sentita ed estesa più la forma di governo può dirsi democratica.
Esistono varie forme di partecipazione alla vita di uno Stato, le forme di partecipazione politiche sono tutelate nella nostra Costituzione nella prima parte al titolo IV.
Diritto al voto significa concorrere all’indirizzo politico-amministrativo dello Stato di appartenenza incidendo sulla composizione dell’organo legislativo e anche esprimendo direttamente la propria volontà tramite forme di consultazioni popolari.
La storia del diritto di voto, nato nella concezione moderna alla fine del 1700, è sempre stato caratterizzato dalla dicotomia della sua natura: diritto proprio dell’individuo o concessione degli stati moderni?
In una dimensione giusnaturalista, in cui alla base della società c’è il libero accordo degli individui, l’assoggettamento ad un potere politico avviene solo tramite il proprio consenso. Le visione giusnaturalista ebbe moltissimi sviluppi teorici che portarono alla previsione di uno Stato assoluto come anche ad una democrazia diretta, o uno stato liberale in cui la maggioranza ha diritto a deliberare e decidere per il resto.
Il diritto di voto si legò in seguito fortemente alla cittadinanza, nozione nata durante il periodo rivoluzionario con l’iniziale evidente obiettivo di portare al potere la classe borghese, e scardinare così il sistema dell’ancien regime basato ancora sul rapporto suddito-sovrano.
Le teorie giusnaturaliste trovarono nella rivoluzione francese un terreno fertile per nuove riflessioni e spunti. Lo stesso periodo culturale che segnò l’inizio dell’idea moderna di cittadinanza ebbe anche la capacità di prospettare un suo superamento formale e teorizzare una cittadinanza universale non basata sul censo, sulla proprietà o sulla condizione sociale.
Nonostante queste spinte universalistiche il legame forte tra voto e cittadinanza sarà utilizzato nelle teorie successive e segnerà fortemente lo sviluppo del diritto di voto.
La dottrina giuspubblicistica si porrà agli antipodi della precedente, teorizzando come lo Stato venisse prima dell’individuo e perciò ridefinendo il diritto di voto nell’ambito di una funzione pubblica. Il voto in questa seconda visione è concesso o negato dallo Stato secondo requisiti assolutamente arbitrari. La questione, per la teoria funzionalistica, non è di dare un diritto all’individuo ma di formare lo Stato conformemente ai bisogni sociali. Tentativi di conciliazione delle opposte teorie di partenza furono tentate cercando di creare, all’interno della dottrina dualistica, la categoria dei diritti pubblici soggettivi, che riconosceva al cittadino in quanto tale alcuni diritti da far valere nei confronti dello Stato. Emerge la necessità di valorizzare lo stretto rapporto tra il popolo e lo Stato, anche perché c'è la presa d’atto dell’opportunità che il potere statale si basi sulla convinzione popolare della sua legittimità. Al cittadino era così riconosciuta la facoltà di diventare organo dello Stato. Questa dottrina fu alla base degli stati liberali di fine ‘800 e permise anche un ulteriore allargamento del suffragio elettorale.
Il dibattito sulla duplicità che emerge nel diritto di voto, il quale viene da una parte indicato come un diritto individuale e dall’altra come una funzione pubblica, non può nascondere il dato storico rilevante che mostra come il percorso del diritto di voto è un progressivo percorso all’estensione, alla inclusione (....) Quali sviluppi possibili? di cosa si discute in Europa? analisi della situazione dello straniero in Italia e cenno sul voto familiare.
La partecipazione della popolazione al governo del Paese è il fulcro della democrazia. Più questa partecipazione è difesa, sentita ed estesa più la forma di governo può dirsi democratica.
Esistono varie forme di partecipazione alla vita di uno Stato, le forme di partecipazione politiche sono tutelate nella nostra Costituzione nella prima parte al titolo IV.
Diritto al voto significa concorrere all’indirizzo politico-amministrativo dello Stato di appartenenza incidendo sulla composizione dell’organo legislativo e anche esprimendo direttamente la propria volontà tramite forme di consultazioni popolari.
La storia del diritto di voto, nato nella concezione moderna alla fine del 1700, è sempre stato caratterizzato dalla dicotomia della sua natura: diritto proprio dell’individuo o concessione degli stati moderni?
In una dimensione giusnaturalista, in cui alla base della società c’è il libero accordo degli individui, l’assoggettamento ad un potere politico avviene solo tramite il proprio consenso. Le visione giusnaturalista ebbe moltissimi sviluppi teorici che portarono alla previsione di uno Stato assoluto come anche ad una democrazia diretta, o uno stato liberale in cui la maggioranza ha diritto a deliberare e decidere per il resto.
Il diritto di voto si legò in seguito fortemente alla cittadinanza, nozione nata durante il periodo rivoluzionario con l’iniziale evidente obiettivo di portare al potere la classe borghese, e scardinare così il sistema dell’ancien regime basato ancora sul rapporto suddito-sovrano.
Le teorie giusnaturaliste trovarono nella rivoluzione francese un terreno fertile per nuove riflessioni e spunti. Lo stesso periodo culturale che segnò l’inizio dell’idea moderna di cittadinanza ebbe anche la capacità di prospettare un suo superamento formale e teorizzare una cittadinanza universale non basata sul censo, sulla proprietà o sulla condizione sociale.
Nonostante queste spinte universalistiche il legame forte tra voto e cittadinanza sarà utilizzato nelle teorie successive e segnerà fortemente lo sviluppo del diritto di voto.
La dottrina giuspubblicistica si porrà agli antipodi della precedente, teorizzando come lo Stato venisse prima dell’individuo e perciò ridefinendo il diritto di voto nell’ambito di una funzione pubblica. Il voto in questa seconda visione è concesso o negato dallo Stato secondo requisiti assolutamente arbitrari. La questione, per la teoria funzionalistica, non è di dare un diritto all’individuo ma di formare lo Stato conformemente ai bisogni sociali. Tentativi di conciliazione delle opposte teorie di partenza furono tentate cercando di creare, all’interno della dottrina dualistica, la categoria dei diritti pubblici soggettivi, che riconosceva al cittadino in quanto tale alcuni diritti da far valere nei confronti dello Stato. Emerge la necessità di valorizzare lo stretto rapporto tra il popolo e lo Stato, anche perché c'è la presa d’atto dell’opportunità che il potere statale si basi sulla convinzione popolare della sua legittimità. Al cittadino era così riconosciuta la facoltà di diventare organo dello Stato. Questa dottrina fu alla base degli stati liberali di fine ‘800 e permise anche un ulteriore allargamento del suffragio elettorale.
Il dibattito sulla duplicità che emerge nel diritto di voto, il quale viene da una parte indicato come un diritto individuale e dall’altra come una funzione pubblica, non può nascondere il dato storico rilevante che mostra come il percorso del diritto di voto è un progressivo percorso all’estensione, alla inclusione (....) Quali sviluppi possibili? di cosa si discute in Europa? analisi della situazione dello straniero in Italia e cenno sul voto familiare.