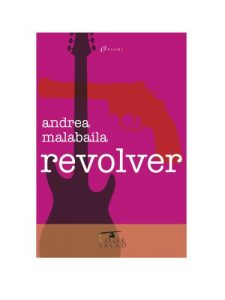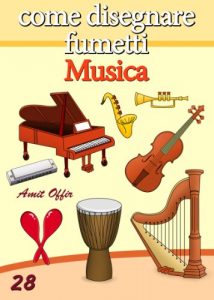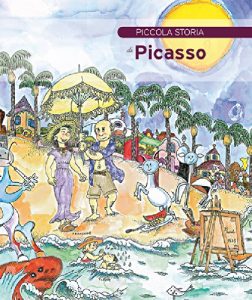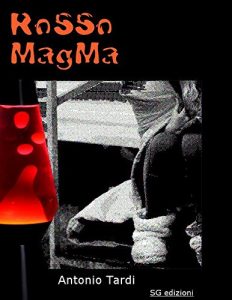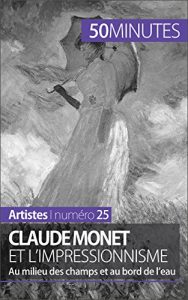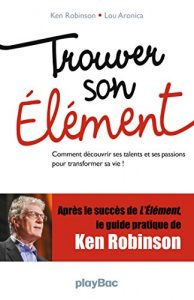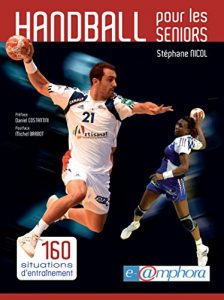I 99eBooks è una directory di eBook. Cerchiamo e classificato intorno alle eBooks Web per te!
Tutti i diritti riservati. I libri e libri elettronici sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Manuale del Jazz
La domanda “Qual è lo stato del jazz oggi?” affiora costantemente lungo tutto il corso della storiografia e critica jazzistiche. E naturalmente ha ricevuto risposte sempre differenti, perché alla sua base vi è un’altra domanda, ancor più generale: “Cos’è il jazz?”. I tentativi di dare risposta a entrambi gli interrogativi raramente hanno tenuto conto di un dato oggi saldamente acquisito dalla storiografia più avveduta: non esiste un concetto o una definizione stabile di jazz, non è possibile definire un’“essenza” del jazz immutabile nei decenni. L’estetica jazzistica ha tentato di metterne a punto i tratti fondamentali (lo swing, l’improvvisazio¬ne, il suono), ma oggi noi vediamo come essi abbiano prodotto solo un’idea purista che non ha mai trovato riscontro nella realtà. È negli anni Trenta che questa idea essenzialista prende progressivamente corpo, mano a mano che si vanno definendo negli Stati Uniti i lineamenti della storiografia jazz: una disciplina che introduce non solo un valore purista, ma procede anche secondo un modello di crescita organica inclusiva. Ovvero: ogni nuova musica è riconosciuta come derivante dallo stile precedente, e anche se la nuova tendenza si pone quale rottura radicale con il passato, ciò che la precede assume il valore di “tradizione”.
Ma questo è solo un aspetto della questione: infatti il punto è che la parola “jazz” nel corso della storia ha assunto sempre significati differenti, che potevano essere legati alla sostanza musicale quanto alla pratica d’uso. La varietà di accezioni che aveva questa parola negli anni Venti è tra le più stupefacenti, a seconda che fosse usata dalle orchestre di società bianche negli hotel di lusso, o dai musicisti neri in locali per proletari, o da intellettuali neri che cercavano di conferire dignità alla musica nera. Negli anni Trenta, ‘Jazz’ e ‘Swing’ erano due musiche profondamente diverse: il primo termine si riferiva alla musica nera degli anni Venti, il secondo alla più commerciale musica per big band. E il bebop, fin dal nome, si poneva come musica con nulla in comune alle due ora citate.
Il modello di crescita organica inclusiva, perfezionatosi dopo la guerra, andò in frantumi negli anni Settanta: la morte di Coltrane, lo spostamento del pubblico verso il soul e il rock, la crisi delle infrastrutture del jazz (club, locali, festival), il crollo delle vendite discografiche, fecero emergere prepotentemente il mosaico di lingue di cui il “jazz” era effettivamente composto mandando all’aria ogni pretesa purista. E si è cominciato a comprendere che forse il concetto di “musica afroamericana” come musica nata dalla diaspora delle culture nere nel mondo è notevolmente più flessibile e funzionale per comprendere un’arte che ha fatto della contaminazione la propria legge distintiva.
Da allora i giornalisti e in qualche misura il pubblico continuano a chiedersi quale sarà “la prossima tendenza” o chi sarà “il prossimo Coltrane”, domande che fortunatamente si sono attenuate negli ultimissimi anni, quando ci si è cominciati a rendere conto che in effetti il jazz procede come sempre su una molteplicità di strade. E non può che essere diversamente: proprio perché figlio della diaspora, il jazz condivide con le altre musiche nere (colte e popolari, scritte e improvvisate, dal ragtime al samba, dal choro al tango, dalla salsa alla cumbia, dal blues al merengue, dal gospel al cajun, per non dire delle musiche africane “madri”) la capacità di dialogare e trasformarsi a contatto con altre culture musicali, per modellarsi a esse e “superarle” producendo una realtà musicale nuova. In quest [...]
Ma questo è solo un aspetto della questione: infatti il punto è che la parola “jazz” nel corso della storia ha assunto sempre significati differenti, che potevano essere legati alla sostanza musicale quanto alla pratica d’uso. La varietà di accezioni che aveva questa parola negli anni Venti è tra le più stupefacenti, a seconda che fosse usata dalle orchestre di società bianche negli hotel di lusso, o dai musicisti neri in locali per proletari, o da intellettuali neri che cercavano di conferire dignità alla musica nera. Negli anni Trenta, ‘Jazz’ e ‘Swing’ erano due musiche profondamente diverse: il primo termine si riferiva alla musica nera degli anni Venti, il secondo alla più commerciale musica per big band. E il bebop, fin dal nome, si poneva come musica con nulla in comune alle due ora citate.
Il modello di crescita organica inclusiva, perfezionatosi dopo la guerra, andò in frantumi negli anni Settanta: la morte di Coltrane, lo spostamento del pubblico verso il soul e il rock, la crisi delle infrastrutture del jazz (club, locali, festival), il crollo delle vendite discografiche, fecero emergere prepotentemente il mosaico di lingue di cui il “jazz” era effettivamente composto mandando all’aria ogni pretesa purista. E si è cominciato a comprendere che forse il concetto di “musica afroamericana” come musica nata dalla diaspora delle culture nere nel mondo è notevolmente più flessibile e funzionale per comprendere un’arte che ha fatto della contaminazione la propria legge distintiva.
Da allora i giornalisti e in qualche misura il pubblico continuano a chiedersi quale sarà “la prossima tendenza” o chi sarà “il prossimo Coltrane”, domande che fortunatamente si sono attenuate negli ultimissimi anni, quando ci si è cominciati a rendere conto che in effetti il jazz procede come sempre su una molteplicità di strade. E non può che essere diversamente: proprio perché figlio della diaspora, il jazz condivide con le altre musiche nere (colte e popolari, scritte e improvvisate, dal ragtime al samba, dal choro al tango, dalla salsa alla cumbia, dal blues al merengue, dal gospel al cajun, per non dire delle musiche africane “madri”) la capacità di dialogare e trasformarsi a contatto con altre culture musicali, per modellarsi a esse e “superarle” producendo una realtà musicale nuova. In quest [...]