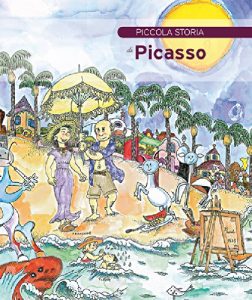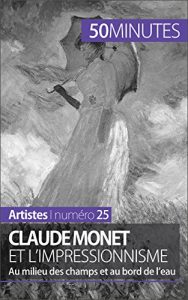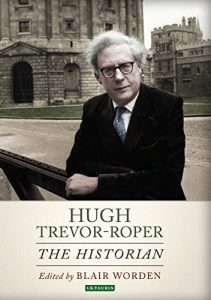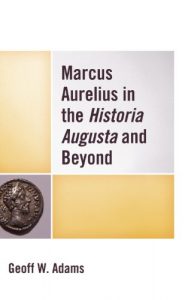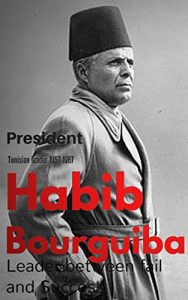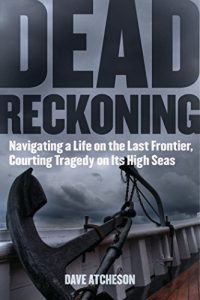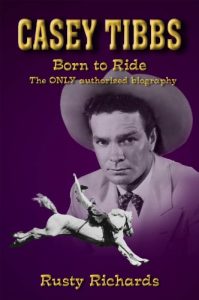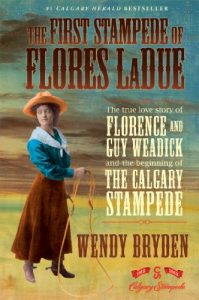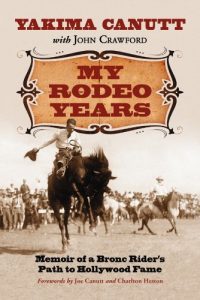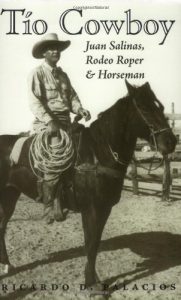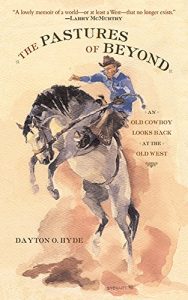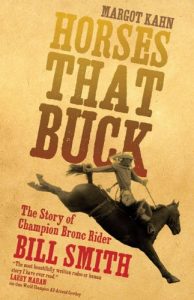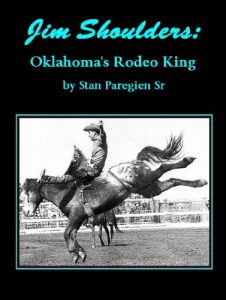I 99eBooks è una directory di eBook. Cerchiamo e classificato intorno alle eBooks Web per te!
Tutti i diritti riservati. I libri e libri elettronici sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Paesaggi della Metropoli della morte: Riflessioni su memoria e immaginazione (Biblioteca della Fenice)
Lo studioso israeliano Otto Dov Kulka ha dedicato tutta la propria opera all’analisi rigorosa e impersonale dell’Olocausto e dei suoi legami con la società tedesca.
Ora, a decenni di distanza, decide di spezzare il silenzio in cui ha relegato la propria esperienza di bambino deportato ad Auschwitz e di far convergere in un unico libro il dato autobiografico e quello storico, rivelando le mitologie elaborate sulla base delle proprie impressioni d’infanzia e confrontandole con la realtà dei documenti e dei resoconti altrui, e con l’immaginario comune sulla realtà dei campi di sterminio. Auschwitz è per Kulka la Metropoli della Morte, su cui domina implacabile la Legge della Morte. Ma è anche il luogo in cui, grazie agli insegnamenti dei malati ricoverati come lui in infermeria, scopre i capisaldi della cultura occidentale, in cui coglie nel cielo primaverile squarci di bellezza assoluta, in cui intona l’Inno alla gioia a poche centinaia di metri dai forni crematori, insieme al coro dei ragazzi del «campo famiglia», l’illusoria isola di normalità creata a uso e consumo degli ispettori della Croce rossa. Ripercorrendo i frammenti del proprio mondo interiore e i luoghi reali in cui un tempo ha vissuto, Kulka fornisce un resoconto straziante e a tratti poetico di cosa significhi essere immersi nell’esperienza dei campi di sterminio, rinchiusi in un mondo dominato dalla Morte da cui è impensabile uscire, oggi come allora.
Ora, a decenni di distanza, decide di spezzare il silenzio in cui ha relegato la propria esperienza di bambino deportato ad Auschwitz e di far convergere in un unico libro il dato autobiografico e quello storico, rivelando le mitologie elaborate sulla base delle proprie impressioni d’infanzia e confrontandole con la realtà dei documenti e dei resoconti altrui, e con l’immaginario comune sulla realtà dei campi di sterminio. Auschwitz è per Kulka la Metropoli della Morte, su cui domina implacabile la Legge della Morte. Ma è anche il luogo in cui, grazie agli insegnamenti dei malati ricoverati come lui in infermeria, scopre i capisaldi della cultura occidentale, in cui coglie nel cielo primaverile squarci di bellezza assoluta, in cui intona l’Inno alla gioia a poche centinaia di metri dai forni crematori, insieme al coro dei ragazzi del «campo famiglia», l’illusoria isola di normalità creata a uso e consumo degli ispettori della Croce rossa. Ripercorrendo i frammenti del proprio mondo interiore e i luoghi reali in cui un tempo ha vissuto, Kulka fornisce un resoconto straziante e a tratti poetico di cosa significhi essere immersi nell’esperienza dei campi di sterminio, rinchiusi in un mondo dominato dalla Morte da cui è impensabile uscire, oggi come allora.