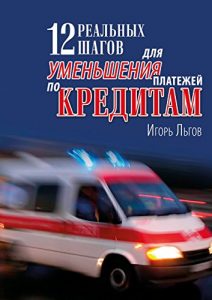I 99eBooks è una directory di eBook. Cerchiamo e classificato intorno alle eBooks Web per te!
Tutti i diritti riservati. I libri e libri elettronici sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Elogio dei giudici: Scritto da un avvocato
Rileggere – o leggere per la prima volta – cosa scriveva questo grande maestro di vita, prima che di diritto, negli anni dal 1935 al 1956, in una serie di aneddoti e di considerazioni piene di humour, provoca nel lettore (in qualunque lettore, anche se sprovvisto di esperienza giuridica) un’emozione da grande scoperta.
Dalle pagine di Calamandrei balza un quadro vivacissimo e pieno di realismo, illuminato da un’aneddotica professionale e da una ricca messe di regolette preziose sulla difficile convivenza tra i due banchi dell’udienza: «L’avvocato deve sapere in modo così discreto suggerire al giudice gli argomenti per dargli ragione, da lasciarlo nella convinzione di averli trovati da sé»; «Il cliente non sa che molte volte, dopo una vittoria, dovrebbe andare ad abbracciare commosso non il suo avvocato, ma l’avvocato avversario»; l’indipendenza dei giudici «è un duro privilegio, che impone, a chi ne gode, il coraggio di restar solo con se stesso, a tu per tu, senza nascondersi dietro il comodo schermo dell’ordine superiore». Calamandrei insiste particolarmente sul motivo della comunanza delle vite parallele: «Il segreto della giustizia sta in una sempre maggior umanità e in una sempre maggiore vicinanza umana tra avvocati e giudici nella lotta contro il dolore: infatti il processo, e non solo quello penale, è di per sé una pena, che giudici e avvocati devono abbreviare rendendo giustizia».
Guardi il lettore il fregio di questo libro: una bilancia nella quale il piatto più pesante è quello che porta una rosa, rispetto all’altro, che porta un codice: la poesia batte il diritto. (dall’Introduzione di Paolo Barile).
Dalle pagine di Calamandrei balza un quadro vivacissimo e pieno di realismo, illuminato da un’aneddotica professionale e da una ricca messe di regolette preziose sulla difficile convivenza tra i due banchi dell’udienza: «L’avvocato deve sapere in modo così discreto suggerire al giudice gli argomenti per dargli ragione, da lasciarlo nella convinzione di averli trovati da sé»; «Il cliente non sa che molte volte, dopo una vittoria, dovrebbe andare ad abbracciare commosso non il suo avvocato, ma l’avvocato avversario»; l’indipendenza dei giudici «è un duro privilegio, che impone, a chi ne gode, il coraggio di restar solo con se stesso, a tu per tu, senza nascondersi dietro il comodo schermo dell’ordine superiore». Calamandrei insiste particolarmente sul motivo della comunanza delle vite parallele: «Il segreto della giustizia sta in una sempre maggior umanità e in una sempre maggiore vicinanza umana tra avvocati e giudici nella lotta contro il dolore: infatti il processo, e non solo quello penale, è di per sé una pena, che giudici e avvocati devono abbreviare rendendo giustizia».
Guardi il lettore il fregio di questo libro: una bilancia nella quale il piatto più pesante è quello che porta una rosa, rispetto all’altro, che porta un codice: la poesia batte il diritto. (dall’Introduzione di Paolo Barile).